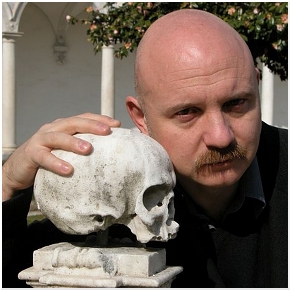
Qual è il teatro di cui sei più amico?
Non voglio fare l’ecumenico, ma mi piace tutto. Dai classici tradizionali, di parola, alla Biennale di Castellucci, che rimane una tra le cose più fantastiche che ho visto. Perché negarsi la bellezza in nome di qualche criterio estetico?
Ultimamente si parla di un Veneto molto fertile dal punto di vista teatrale. E’ una fertilità che, secondo te, si avverte anche nella scrittura di testi teatrali?
La fertilità è nel fare, o nello scrivere per se stessi; meno nella richiesta drammaturgica di autori. Perché quando scrivi un libro, bene o male lo pubblichi, trovi sempre una piccola o media casa editrice. C’è grande interesse e spazio per gli autori. E’ molto più complesso scrivere un testo teatrale, per investimento di tempo, di soldi. Quindi o prendi l’occasione produttiva che l’epoca ti offre, come fu con Pantakin nel 2007 per il centenario goldoniano, altrimenti sei destinato a scrivere un file che molto probabilmente resterà su carta o neanche, perché è molto più semplice pubblicare poesie, nonostante non abbiano mercato, che pubblicare un testo teatrale. Oggi tutta l’Italia, intesa come tutte le classi sociali, scrive romanzi. Ultimamente è uscito il romanzo di Franceschini, di Bianconi (il cantante dei Baustelle), della Marchesini… In corsa per lo Strega c’è un’autrice di Vicenza che ha vinto il premio Calvino e non arriva già dal conosciuto.
E’ significativo che pochi scrivano per il teatro, che siano pochi quelli che vengono messi in scena, e giustamente le stesse compagnie dicono: “Me lo scrivo da solo il testo”.
Questa fioritura di letteratura e di teatro (forme povere, minoritarie, rispetto al cinema e alla televisione) che c’è in Italia e in Veneto non la vedo come ripiego, ma come sintomo di campi liberi, di zone temporaneamente autonome, come si diceva negli anni ‘80. Le realtà singole, le solitudini disseminate si esprimono con la letteratura, il romanzo, il teatro. Il romanzo è una pratica della solitudine, è quasi una specie di esperienza della solitudine. Devi stare solo quando scrivi, ti devi confrontare angosciosamente, o a volte felicemente, con la tua solitudine.
Me la spiego un po’ così questa enorme fertilità, statisticamente imparagonabile a qualche anno fa. Specialmente nel romanzo c’è quasi un’inflazione, secondo alcuni. E così anche per il teatro: se sei un gruppo di persone che ha una forza performativa, come fai altrimenti? Come puoi avere accesso ad un film o ad altre cose? Col teatro si può fare.
A proposito della scrittura Pier Paolo Pasolini affermava: “[…] Mi sembra una cosa completamente priva di senso, continuo a essere scrittore per inerzia, per forza d’abitudine, ho iniziato a scrivere poesie a sette anni e mezzo e non mi sono chiesto perché lo facessi, ho continuato a scrivere per tutta l’infanzia, l’adolescenza ed eccomi qui a scrivere ancora, l’unico senso possibile è un senso esistenzialistico, l’abitudine a esprimersi…”. Che senso ha per te?
La letteratura, i romanzi, le poesie: cosa sono queste cose? Chiamiamole con un termine ancora più generico, opere. Cos’è un’opera? E’ una sfida che ti dai. Guarda la vita, come passa nelle incomprensioni quotidiane, nelle distrazioni, nell’accidia, che non è solo pigrizia, è anche una continua inconcludenza, dovuta dall’essere captati da mille richiami, stimoli. Secondo me la scrittura è quell’impegno che ti prendi verso la vita di dare forma all’opera, che è anche un po’ andare contro il tuo tempo, perché è un non tempo. Quando sei dentro all’opera, sei dentro a un tuo progetto. L’epoca ti chiama, ti vuole, ti sequestra, ti fa stare sul pezzo. Qual è la notizia del giorno, l’incombenza, il mio dovere, la commissione che devo svolgere? Tutto questo è l’oggi, il quotidiano con la sua necessità, e poi c’è il tuo progetto, che io per l’attività che mi sono scelto chiamo opera. Tutto il resto è quello che vogliono gli altri da me: attualità, giornalismo esistenziale. E’ agenda. Ma c’è anche un’agenda più profonda, che non ha lunedì, martedì, che non ha data, ma è un filone costante, sotterraneo. E’ un tempo senza nome, che è il tempo dell’opera, e quel tempo lo decido io. Non è il tempo dell’obbedienza. Quando devo scrivere un articolo obbedisco: devo trovare qualcosa di attuale, ho la scadenza del giornale…, mentre nell’opera obbedisco all’opera stessa, ai suoi tempi, alla sua forma. Questo è completamente incommensurabile, diverso, rispetto alla presenza del tempo che ci è data vivere, e nella quale siamo un po’ costretti a vivere.
Per questi motivi mai come quando sei nell’opera ti senti presente, senti una sincerità, un’autenticità, un’intensità. Mentre altrove sei chiamato a rispondere a stimoli, a richieste, e allora compi dei gesti passivi, nell’opera tutto è tua responsabilità. Certo, aumenta anche il senso di colpa, l’angoscia, perché nessuno ti garantisce che quello che stai facendo ha un valore. Per me lo scrivere è questo, un modo di essere dentro all’opera, senza obbedire al ricatto dell’attualità, del tempo presente, della cronicità delle giornate; un modo per esserci in maniera più vera, nel tempo e dentro il tempo. Una volontà attiva. Questo ho saputo fare.









