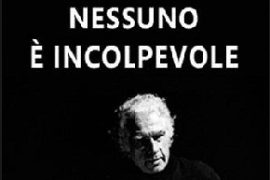Come si racconta un genio? Di certo non è affare semplice: il rischio di scivolare nei gorghi insidiosi della sterile aneddotica o della cronaca didascalica è molto alto. Soprattutto se il genio in questione è Giorgio Strehler, personalità sanguigna, malinconica, molto spesso prevaricatrice che, nonostante le vistose complessità, diversità, e anche follie, ha contribuito a rivoluzionare il teatro italiano del Novecento.
Alessandro Turci, con il suo documentario “Strehler, com’è la notte?”, presentato in anteprima alla 39^ edizione del Torino Film Festival nella sezione Fuori Concorso/Tracce di Teatro, supera abilmente questo rischio con una narrazione accorta e affettuosa sulla vita estrosa, non di rado umorale, del regista che ha contribuito a svecchiare per sempre la scena teatrale.
Ricorda bene, nella pellicola, Giancarlo Dettori, uno degli attori di punta in svariati allestimenti meneghini: “Da lui in avanti le cose cambiano completamente, Strehler comincia a pensare a una nuova forma di teatro, più democratica, e apre le porte al teatro epico”.
Girato in occasione dei cento anni dalla nascita del grande Maestro, scritto insieme a Federica Miglio e Antonia Ponti, il film è coprodotto da Dugong Films e Rai Documentari, in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Cento minuti di durata, probabilmente non molti per un’esistenza tanto piena, ma sufficienti per restituire al pubblico, attraverso una cospicua serie di nozioni, aneddoti, riferimenti e contraddizioni, il tracciato singolare di una carriera straordinaria.
È un viaggio che intreccia poesie, performance, fotografie, lettere, interviste a collaboratori e amici, riflessioni sull’arte e sul teatro, materiali d’archivio e documenti provenienti dalle teche RAI, dal Museo Teatrale Carl Schmidl di Trieste, dalla Fondazione Cineteca di Milano e dall’Archivio Storico Teatro Alla Scala. Contributi da cui emerge con forza lo speciale temperamento di Strehler, uomo e artista, e la portata culturale che ha lasciato in eredità.
Sono tante le voci che raccontano questa storia: da Ornella Vanoni a Claudio Magris, da Dettori a Rosanna Purchia, da Franca Cella ad Andrea Jonasson, da Giulia Lazzarini a Franca Squarciapino, e ancora Ezio Frigerio, Pamela Villoresi, Vittoria Crespi Morbo, Maurizio Porro, Franca Tissi e Stefano Rolando. Testimonianze che tratteggiano una figura nitida, a tutto tondo, di uno Strehler completamente fuso con quell’universo teatrale che ha condizionato ogni sua azione, ogni suo pensiero, ogni sua scelta.
Che fosse un’anima vanesia e collerica, è ormai risaputo, ma ciò che si coglie in questi frammenti è un’energia inarrestabile, capace di sprofondare in momenti cupi e irascibili, così come di sviluppare geniali creazioni e sodalizi artistici fortunati, tra tutti quello con Paolo Grassi. Assieme nel 1947 riescono a farsi affidare, dal Comune di Milano, Palazzo Carmagnola in via Rovello, in precedenza luogo di tortura dei fascisti della Muti della Repubblica di Salò. Una piccola sala con cinquecento posti a sedere, piena di calcinacci e tutta da rifare. Lì nasce il Piccolo Teatro, il primo teatro stabile di prosa in Italia, inaugurato con la rappresentazione “L’albergo dei poveri” di Maksim Gorkij. Un’amicizia profonda, quella tra i due, costellata anche da clamorose sfuriate con cui Grassi cercava di mettere ordine nella sua turbolenta vita sentimentale, di richiamarlo alla disciplina quando si lasciava andare al turpiloquio o accumulava debiti, di evitargli spese inopportune. Tanto che, nel carteggio, c’è per esempio una lettera che riporta: “Per carità Giorgio tu fai ciò che vuoi e ovviamente compra la macchina che vuoi. Io però posso dirti che NON DOVEVI prendere una macchina così vistosa, così appariscente, così da pescecane, così poco marxista, così capricciosa, così di lusso!”.
Ma aldilà delle frivolezze a cui si abbandona, Strehler sa perfettamente cosa vuole: un teatro popolare ma allo stesso tempo sofisticato, che abbia una missione pedagogica e di impegno civile, votato alla coscienza etica e che metta al centro l’uomo. È teatro e, nel contempo, è politica, soprattutto nella scelta delle opere da presentare al pubblico. Con Čechov porta in scena l’immunità del rango nobiliare, con Goldoni l’ingiustizia sociale degli umili, con Shakespeare i tradimenti di corte, con Brecht l’ineguaglianza di classe e le contraddizioni della religione. E proprio l’incontro con il drammaturgo tedesco è decisivo. Brecht arriva a Milano nel 1956 per assistere alle prove dello spettacolo “Opera da tre soldi” e rimane talmente colpito dalla regia strehleriana da decidere di affidare tutta la sua opera al Piccolo Teatro.
Sulla scia di questo sodalizio intellettuale, nel 1963 debutta “Vita di Galileo” con Tino Buazzelli, che registra più di cento repliche. Una pièce lunghissima, dall’atmosfera ieratica, controversa (Galileo non era ancora stato sdoganato) e definita in una lettera del regista agli attori “un atto di vita morale”.
“Che cosa mi ha insegnato Bertolt Brecht? Mi ha insegnato, meglio di quanto non l’avessi fatto prima, un teatro umano. Un teatro che, divertendo, aiutasse gli uomini a essere migliori. Mi ha insegnato la dignità di lavorare nella società e per la società, dentro la storia e i problemi del mio tempo”.
Tutto il resto è vita che scorre: le donne, dalla prima moglie Rosita Lupi a Ornella Vanoni, che lui inventa “cantante della mala”, da Valentina Cortese ad Andrea Jonasson; i trionfi mondiali ed europei; le contestazioni giovanili alla fine degli anni ’60 da parte della nuova scena teatrale; la politica e l’esperienza prima da europarlamentare per il Partito Socialista, poi da deputato della Sinistra Indipendente.
Dalle immagini sullo schermo emerge preponderante il valore di un uomo estremo, nel teatro come nel privato, che si è assegnato il compito di narrare l’umanità nella sua bellezza come nella sua bruttura.
Il documentario – che esce celebrando i cento anni dalla nascita del regista – sarà trasmesso il 28 dicembre su Rai 3.
STREHLER, COM’È LA NOTTE?
Regia: Alessandro Turci
Sceneggiatura: Federica Miglio, Antonia Ponti, Alessandro Turci
Produzione: Dugong Films, RAI Documentari
Coproduzione: Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Museo Teatrale Carl Carlo Schmidl, Comune di Trieste, Fondo Giorgio Strehler della Fondazione Cineteca di Milano, Archivio storico Teatro alla Scala
Nazione: Italia
Anno: 2021
Durata: 105 minuti
Visto a Torino, 39° Torino Film Festival, il 29 novembre 2021