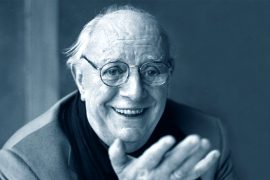Avranno già detto tutto il dicibile per questi dieci anni di assenza (ma era già “assente”, a suo dire, da sempre): intellettuali, amici di sempre, nemici, studiosi e uomini di teatro che lo hanno frequentato.
Io sono nato troppo tardi per essergli amico, nemico o per frequentarlo sulle scene. E non sono un intellettuale o uno studioso. Sono solo un uomo di teatro.
L’unica cosa che mi lega a Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene (questo il suo nome completo) è la provenienza: il Salento. Non è cosa da poco.
Da sempre, per darmi un tono, vado in giro dicendo che il Salento ha sfornato alcuni dei più grandi innovatori del ‘900: Tito Schipa, Domenico Modugno, Carmelo Bene e Franco Causio. E da sempre asserisco che non è un caso. E’ questione di terra.
Il Salento fino a pochi anni fa, prima che pizzica, taranta e oleografie varie ne facessero terra di saccheggio turistico, era un luogo ben al di sotto di Eboli, e non c’era Cristo che passasse su questa terra. La sensazione netta era di trovarsi su un’“isola” ancorata malamente alla terraferma. Anche i collegamenti ferroviari e stradali lo dichiaravano con disarmante evidenza: da Bari in giù sembrava non finisse mai. Con questo senso di “isolamento” – ma anche di identità – sono cresciuto durante l’infanzia e l’adolescenza, e così mi piace pensare siano cresciuti anche quegli uomini eccellenti cui mi accodo indebitamente e solo per questa comune provenienza.
E nell’isolamento – nello stare sull’isola – tutto è possibile, ogni “visione” può prendere forma e sostanza poiché non trova ostacoli, crescendo nell’indifferenza degli altri isolani salentini e senza trovare contrapposizioni oltremare, laddove comincia la terraferma Italia. L’isolamento – la mancanza di confronto – è la pre-condizione per immaginare “altro”, per innovare, per buttarsi oltre, in modo guascone, senza legacci e steccati imposti dalla tradizione o dal “si è sempre fatto così”. Quando non c’è confronto, non conosci le regole e il come/cosa fanno gli altri e ti proponi con la tua “visione guascona” del mondo.
Questo è accaduto a Schipa e gli altri: sono partiti dall’isola con una visione nuova e incosciente, una visione che non teneva conto del resto del mondo.
Così Raffaele Attilio Amedeo Schipa (detto Tito) poté innovare alla radice il modo di cantare, imponendo, all’inizio del secolo scorso, la traccia sulla quale, ancora oggi, si muove ogni cantante lirico degno di questo nome. Spogliò dai fronzoli la linea melodica, cantò con estrema precisione ciò che c’era scritto sullo spartito, inventò un’emissione “naturale” della voce abolendo il “falsetto”, controllò il mezzo vocale con una grazia infinita, divenendo un punto di riferimento assoluto ancora insuperato (provate ad ascoltare “L’elisir d’amore” cantato da lui e ditemi se c’è versione più moderna di quella!).
Così Domenico “Mimì” Modugno poté scagliare al vento la sua giacca dal palco di Sanremo, cantando la canzone italiana più eseguita al mondo in tutti i tempi e diventando il vero padre della canzone d’autore italiana. Guascone fu quel lancio e guascone fu il primo impatto di Mimì con il mondo dello spettacolo: si presentò ventenne ai provini del Centro sperimentale di cinematografia e, davanti alla telecamera che aveva immortalato già diverse Giuliette, Romei, Nine e Mascie, non avendo niente di pronto, raccontò semplicemente una barzelletta, impastando una neolingua tra dialetto leccese e italiano. Ovviamente passò il provino tra lo stupore degli altri candidati azzimati e “classicheggianti”.
Così Franco Causio, che ribaltò le traiettorie del campo di calcio, rinnovando completamente il ruolo dell’ala destra, sempre in bilico tra guasconeria ed eleganza, tanto da meritare l’appellativo di “Barone del calcio italiano”. Impossibili le sue geometrie sul campo e impossibili le sue acrobazie linguistiche: – Come ha fatto a sbagliare quel gol? Gli ho pennellato un cross che sembrava un quadro di Pirandello! -, dichiarò con fare guascone in una diretta televisiva.
Non sapremo mai se si riferisse a Raffaello o Donatello (peraltro scultore), ma il senso del paragone era lampante.
E così Carmelo Bene fece saltare il banco, qualunque banco gli si presentasse davanti, e macchiò in modo indelebile il teatro del ‘900 con la sua presenza/assenza. Guascone per statuto, mancò ogni occasione di contatto con il resto del mondo, inventando se stesso dal nulla, perché dal nulla che era l’isola Salento era venuto. Portò alla ribalta l’isolamento, quel nascere di una “visione” nuova e incosciente da se stessi, senza altri riferimenti. In questo, Carmelo Bene, fu salentino fino al midollo, fino alla rappresentazione forzata di se stesso come auto-isolato dal mondo. Rifiutato dalla sua terra, volle rivelarsi come il frutto di una partenogenesi (e il suo teatro fu tale per davvero).
La sua terrà lo rifiutò per anni. Questo lo ricordo. Perché se non ho avuto modo di frequentare l’uomo direttamente, la mia infanzia e la mia adolescenza sono piene di testimonianze indirette, di vox populi, mai verificate e mai smentite, che acquistano valore non per il loro contenuto, ma per raccontare la visione che il Salento aveva di quel figlio maledetto.
Non si contano le volte che, prima di saper leggere e scrivere, l’ho sentito nominare da chiunque come spauracchio, come oggetto di venerazione terrifica o di ribrezzo, quasi come una bestia mitologica. Era una sorta di mau-mau da proporre ai bambini discoli: “ddiventi comu lu Carmelu Bene!”.
Poi fu l’epoca dei “conoscitori-detrattori” che avevano avuto modo di incrociarlo da giovane. Per alcuni di loro era semplicemente pazzo, sin da bambino, e “menomale che se n’è andato dal paese: cu bba’ fazza danni a n’autra parte!” (che vada a fare danni da un’altra parte). Per qualcun altro era talmente balbuziente a scuola che “non so come fa mó a stare nel teatro”. Qualcuno non poteva negare la fascinazione, perché se è vero che “alle interrogazioni balbettava, quando leggeva Dante, però, era un qualchecosa di commovente, che l’aria in classe restava sospesa e il professore piangeva”.
Altri ancora raccontavano di vaghe molestie di genere erotico di cui, a loro volta, avevano sentito dire e “quindi: non so se verità; ma se nni spìi a ‘nfacce [se lo guardi in faccia] non è che pare poi così strano”.
E ancora: arrivarono i “detrattori e basta”, quelli che non l’avevano neanche incrociato ma ne avevano sentite abbastanza per sentenziare o insinuare. “Quello è una presa per il culo, perciò se n’è andato dal Salento. Noi l’avevamo capito da subito” mi disse un assessore del Comune di Otranto, fiero della sua incapacità di rintracciare il pur minimo significato nei pensieri e nelle parole di quell’uomo. Peccato che pochi mesi dopo, quando Carmelo Bene eleggeva quella città per trascorrere gli ultimi anni della sua vita, glielo leccò il culo, sperando di poter apparire in qualche foto sui giornali accanto al “Maestro” (così ne parlava poi, pur continuando a chiedersi: Maestro di che?).

Ora, essendo il Maestro tornato a casa, era giunto il momento per “detrattoconoscitori-adulatori-leccaculi-e-basta” di mal sopportarlo perché, la venerazione che il resto del mondo gli tributava, insinuò qualche dubbio tra le pieghe del rifiuto atavico e, per di più, moltiplicò a dismisura l’attrazione/repulsione verso quell’oscuro oggetto del desiderio.
Cominciarono a girare aneddoti che ne fecero un fenomeno da baraccone da andare a spiare, con la complicità, peraltro, delle guasconerie di Carmelo Bene.
Rimase notabile in quegli anni la volta che, prima del ‘concerto d’autore’ da “La figlia di Iorio”, mugugnava nel microfono e da dietro le quinte, chiedendo di “spostare” quegli astanti sul balcone, altrimenti lo spettacolo non sarebbe iniziato. Si era all’aperto, nel piazzale davanti alla cattedrale di Otranto e dei signori erano affacciati al loro balcone (come ogni sera, forse) assolutamente indifferenti a ciò che stava per accadere. Ma lui li volle “spostati”. E tali furono. E già qui, saliva il mormorio della gente in sala e anche il terrore che l’epifania non avvenisse.
Iniziò lo spettacolo ma lui, non contento, si lamentò di un cane randagio infiltrato tra le poltrone della sala: se avesse emesso un solo guaito lo spettacolo sarebbe stato immediatamente interrotto. A questo punto la gente non era più seduta sulle sedie ma congelata in una polaroid di gruppo, e ognuno muoveva gli occhi soltanto per seguire che facesse e dove andasse il cane. Sarà stata la forte pressione cui erano sottoposte le menti o l’invasamento mistico in cui le aveva sprofondate la voce del “Maestro”, ma molti, ancora oggi, giurano che il cane si accovacciò nel corridoio tra le sedie, puntò il muso verso gli occhi spalancati di Bene e ascoltò in religioso silenzio l’intera serata.
Non sto a dire del “funerale da vivo” che chiese alla città di Otranto, o di altre guasconate raffinatissime dell’uomo perché, tra un vociare e una diceria, infine, arrivò la morte, quella fisica.
E da quel momento tutto il Salento si tappezzò di luoghi memorabili: “Qui ha dormito Carmelo Bene”, “qui ha mangiato”, “qui ha preso un caffè”, e siamo ancora in attesa che qualche assessore di lunga memoria apponga una lapide su un cantone con scritto “qui ha pisciato Carmelo Bene”.
Una però, tra le tante voci arrivate alle mie orecchie, mi rimane addosso ancora oggi, come a bilanciare tutto quello che, tra vita, morte e miracoli, aveva contribuito a farne un paladino dell’assenza, un fustigatore dell’essere, la negazione fatta persona (dis-fatta persona, avrebbe detto lui). Forse perché quella “voce” è di prima mano.
Forse perché quella voce separa l’uomo dal personaggio, nel senso che, mentre ci restituisce l’uomo, rende ancora più stupefacente la coerenza del personaggio che interpretava nella vita, ne mette in luce lo sforzo titanico perpetrato nel tempo, lo sforzo di essere identico a se stesso nonostante il passare degli anni e le continue insidie dell’uomo celato sotto al personaggio.
La “voce” è quella di un infermiere salentino, conosciuto proprio in quegli anni in cui Carmelo Bene si era trasferito ad Otranto.
Pochi mesi dopo aver chiesto i “funerali da vivo” ai cittadini di Otranto dichiarando “ho la morte addosso, ma non ne ho affatto paura”, accadde l’ennesimo malore e l’ennesimo ricovero d’urgenza (seguiti dall’ennesima resurrezione).
Tra i barellieri che conducevano Bene nei corridoi dell’ospedale c’era proprio questo infermiere. Nella concitazione del momento, questi aveva afferrato la barella come poteva e la sua mano era capitata accanto alla mano di Bene, il quale, sentendo quel contatto, strinse con forza il polso dell’infermiere e guardandolo negli occhi lo supplicò con un filo di voce: “Non fatemi morire, non fatemi morire…”.
L’infermiere me lo raccontò con l’atteggiamento di chi sa, per esperienza, che in certi momenti siamo tutti uguali – altro che “genio” e “io sono morto da sempre” -, con una compassione sincera, nel senso etimologico di “essere con l’altro nel soffrire”.
Ora, non so se il suo fu l’ennesimo “fatto” rivisitato e corretto ad uso e consumo del mito Carmelo Bene, non so se io stesso l’ho riportato ammantato di un qualcosa che nell’originale non c’era, ma mi piace pensare che sia andata proprio così, che in quel momento “l’uomo” Carmelo Bene abbia avuto paura dell’“isolamento”, di tornare a quel nulla da cui era venuto.

Mario Perrotta (attore, autore e regista teatrale) nasce a Lecce nel 1970.
Nella periferia della città (costituita da campi incolti e palazzi di sette piani) impara da piccolo: il gioco del pallone praticato sui “petruddhuli” ( pietriccio, ghiaino, materiale inorganico pre-urbano), il dialetto leccese (assolutamente vietato in casa con la madre ma non a casa dei nonni), le mazzate di sopravvivenza (forma di scontro fisico quotidiano, atta a dimostrare che non hai paura anche quando ce l’hai) e la leggerezza dell’essere (praticata arrampicandosi sulle impalcature dei palazzi in costruzione giocando “a chi arriva più in alto”). […]
Naturalmente predisposto alle materie umanistiche si iscrive ad ingegneria a Bologna: il giorno dopo il primo esame, passato con successo, cambia facoltà scegliendo filosofia.
Nel 1989/90 frequenta per pochi mesi una scuola di teatro e poi, insoddisfatto, un’altra scuola teatrale sempre a Bologna, ricavandone poco didatticamente: è qui però che nasce il nucleo fondatore della Compagnia del Teatro dell’Argine. […]