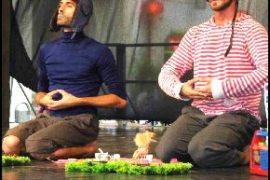Il coreografo Stefano Mazzotta e il cineasta Massimo Gasole trasformano in film il romanzo “I poveri” di Raul Brandão
Una Sardegna ispida e polverosa. Una danza rocciosa come le montagne, spoglia come i rami secchi degli alberi e gli arbusti arsi da un sole abbacinante.
Il tempo logora le architetture e spopola i borghi. Scalfisce i muri, da cui si staccano calcinacci ingialliti. Scrosta infissi e serramenti.
Il tempo è polvere. Si accumula nelle case vuote. Si sedimenta sugli oggetti fossilizzandoli. Il tempo è un sasso nelle mani di un anziano, levigato dagli elementi.
È il Cinemino di Milano, zona Porta Romana, ad accogliere la proiezione di “Elegia delle cose perdute”, progetto di danza, teatro, cinema e fotografia prodotto dai torinesi di Zerogrammi.
Stefano Mazzotta, coreografo e regista, e Massimo Gasole, cineasta, realizzano un mediometraggio che parte dal libro “Os pobres” di Raul Brandão (1867-1930), uno degli autori più sorprendenti della letteratura portoghese. Ne nasce un affresco verista con al centro un’umanità derelitta. Stilemi che rimandano a Dostoevskij e si intrecciano alla poetica di Grazia Deledda, agli arcaici modi di una Sardegna rurale, ai miti e simboli che la popolano, ai sentimenti profondi che pervadono i suoi abitanti.
Affiora nel film, nella danza dei poliedrici protagonisti (Alessio Rundeddu, Amina Amici, Damien Camunez, Gabriel Beddoes, Manuel Martin, Miriam Cinieri, Lucrezia Maimone, Simone Zambelli, con Sara Angius, Elisa Zedda e la partecipazione speciale di Antonio Piovanelli, Bonaria Ghidoni, Loredana Parrella) una sorta di realismo magico. Scie immaginifiche per parlare di solitudine e amore, di follia e di morte. E una miseria materiale e spirituale che lascia crepe per la redenzione.
La compagnia torinese si distingue per un intreccio di linguaggi che, partendo dal corpo e dalla coreografia, sconfina nei territori dell’immagine: quella bidimensionale della fotografia; quella tridimensionale del cinema. Quest’arte attinge alla solidità del teatro e alla robustezza delle arti circensi.
Il Cinemino è una piccola sala sotterranea nel contesto di una palazzina signorile di inizio Novecento, vicinissima al Teatro Franco Parenti. È sormontato da un bistrot con tavolini al chiuso e all’aperto, dove si può mangiare a prezzi modici e fruire di una mini-biblioteca. Un posto informale e accogliente, con una programmazione d’essai a getto continuo, poltrone comode e un buon impianto di sonorizzazione.
Proprio l’impianto sonoro aiuta ad apprezzare il mediometraggio, realizzato con il contributo di INTERCONNESSIONI_residenze artistiche in Sardegna (direzione Simonetta Pusceddu / Tersicorea) e girato tra i comuni di Settimo San Pietro, Selargius e Quartucciu.
Il crepitio dei passi. Il fruscio delle scarpe sul selciato. Il fragore secco della terra dissodata da una vanga. Il vibrare caldo delle corde della chitarra. Lo stridore avvolgente dell’archetto sulle corde di viole e violini.
Una danza lenta e sofferta. Il sogno di un pazzo. Il delirio di un clown. Il dolore sconnesso di una donna vestita di nero. Figure dall’incedere meccanico, dallo sguardo assente come i personaggi di Kantor, perennemente sul crinale tra vita e morte.
Il pianto. Una nostalgia muta, che fuoriesce attraverso il corpo, con coreografie anchilosate fatte di spasimi e sincopi.
Il paesaggio nuragico della Sardegna è orizzonte inaridito e abbandonato. In questa terra delle anime desolate la telecamera rimane ferma. Ci consegna un romanzo fotografico a quadri.
La tavolozza dei colori è tenue. I piani lunghi e lunghissimi si stagliano su un orizzonte drammatico tanto più inquieto quanto più in contrasto con la luminosità di questo Sud mediterraneo, rupestre, preistorico. L’occhio fermo, frontale, della macchina da presa, indaga i colori e ne lascia inalterato il mistero.
Il mare delle cinque del mattino. Il vento dirompente di un ferragosto riarso. Queste creature appartengono alla morte. Annusano la propria decomposizione. Ma non sanno razionalizzarla. Non trovano requie.
Un senso d’esilio pervade le coreografie di personaggi irrelati, irrisolti, che trovano un’idea di vicinanza e di comunità al contatto con l’acqua, sinonimo d’annegamento, allegoria di naufragio, invito all’attraversamento, simbolo di rinascita. Il mare fa tutt’uno della vita e della morte. Avvia la risurrezione di corpi fermi come le inquadrature, dopo un’ultima cena dove anche il cibo è celebrazione dell’assenza.
Costumi e oggetti antichi. Tutto è fisso: il dolore, gli sguardi, i ricordi, la danza. Donne smarrite ed esiliate. Uomini disarticolati e disintegrati. Tutti hanno un lutto da elaborare. Piangono le cose le persone, sé stessi. Sono zombie nella penombra. Celebrano il proprio funerale prima di scavarsi la fossa con le proprie mani.
Stefano Mazzotta, scuole Koreja e Paolo Grassi, artista multimediale in assiduità con il “terzo teatro”, interseca danza coreutica, letteratura, fotografia e arti plastiche. E trova il pharmakon nella ferita stessa. I danzatori metabolizzano la propria morte quando ne diventano coscienti. La superano nella coralità che conforta il dolore. Danno forma a una danza unanime, dove coesistono magia e follia.
Un naufragio in un Sud ancestrale. Una viaggio che ricorda “Miracolo a Milano”, ma anche il sogno di un matto in “Train de vie”. Paesaggi panoramici e umani alla Isabel Allende. Volti segnati dal logorio della vita. Primissimi piani e panoramiche alla Sergio Leone.
Il trito “Valzer n° 2” di Shostakovich avvia una danza corale spigolosa, ancora più suggestiva perché inquadrata dall’alto. Svasata. Mai a tempo con la musica. Ed è proprio nel dinamismo che ne deriva che fa capolino il riscatto di questo Sud rurale e selvatico refrattario ai percorsi turistici, come araba Fenice pronto a risorgere dalle proprie ceneri.
Un inno alla vita che non sconfessa la morte. “Elegia delle cose perdute” è un fiume di lacrime, di grida, di mistero. L’onda nuvolosa mette a nudo le radici più profonde. Il torrente porta con sé sventure e risa; senza posa, trascina questa terra umana verso una spiaggia dove le mani squallide di chi ha sofferto trovano finalmente la mano che le sostiene. Dove gli occhi dei poveri, che ne hanno abbastanza di piangere, si stupiscono all’alba eterna, dove il sogno diventa realtà.
“Elegìa delle cose perdute – un diario fotografico” è anche un volume (Edizioni Storiedivento) contenente le fotografie realizzate da Mazzotta durante le riprese del film.
Elegìa delle cose perdute
soggetto, regia e coreografie Stefano Mazzotta
una riscrittura da/a Os Pobres di Raul Brandao co-regia Massimo Gasole
progetto realizzato con il contributo di INTERCONNESSIONI_residenze
artistiche in Sardegna – direzione Simonetta Pusceddu/Tersicorea
creato con e interpretato da
Alessio Rundeddu, Amina Amici, Damien Camunez, Gabriel Beddoes, Manuel Martin, Miriam Cinieri, Lucrezia Maimone, Simone Zambelli | e con Sara Angius, Elisa Zedda | con la partecipazione speciale di Antonio Piovanelli, Bonaria Ghidoni, Loredana Parrella
collaborazione alla drammaturgia Fabio Chiriatti, Anthony Mathieu
operatori di ripresa Massimo Gasole, Damiano Picciau
riprese aeree Alberto Masala
montaggio Massimo Gasole
mix audio Emanuele Pusceddu
color grading e direttore della fotografia Damiano Picciau
trucco e parrucco Federica Li
costumi e scene Stefano Mazzotta
luci Tommaso Contu
segreteria di produzione Maria Elisa Carzedda
produzione Zerogrammi
in collaborazione con Tersicorea_Officina delle arti sceniche, Illador Films, Casa Luft, Arca del tempo, Festival Danza Estate, C.ie La meme balle, La nave del duende
con il contributo di Twain _ periferie artistiche_centro di residenza della Regione Lazio | con il sostegno di Mic_Ministero della Cultura, Regione autonoma della Sardegna, Regione Piemonte, Fondazione di Sardegna, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna, Comune di Settimo San Pietro, Comune di Selargius, Comune di Quartucciu, Ce.D.A.C Sardegna_circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo | un ringraziamento a Elisabetta Milia, Alessandro Baldussi, Sandro Perra, Raffaele Lai, Angelo e Sara Fadelli, Salvatore Medda, Valentina Tibaldi, Silvia Battaglio, Cooperativa Specus, Cooperativa Bios
durata: 1h